Sono disponibili gli ultimi posti per le visite guidate alla Palazzina Malvezzi Campeggi, già Legnani, organizzate sabato 15 e domenica 16 maggio nell'ambito delle Giornate di Primavera del FAI - Fondo Ambiente Italiano, un appuntamento sempre molto atteso e apprezzato da castellani e visitatori, organizzato nel rispetto delle normative per la prevenzione del contagio da Covid-19.
Un'occasione più unica che rara per conoscere questo perfetto esempio di villa bolognese, che si trova in via San Giorgio 1848 a Castel San Pietro Terme, che normalmente è chiusa al pubblico perché di proprietà privata.
Sia sabato che domenica sono previsti turni di visita dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con prenotazione obbligatoria on line sul sito https://fondoambiente.it/luoghi/palazzina-legnani-malvezzi?gfp (contributo suggerito a partire da 3 euro).
In più, in entrambe le giornate, alle ore 17, si potrà partecipare a "Un tè con l'agronomo", evento speciale di raccolta fondi, con prenotazione obbligatoria al numero 370 3507649 (contributo suggerito a partire da 15 euro). Esplorazioni storiche, botaniche e letture ad alta voce, accompagnati da un esperto, sorseggiando una tazza di tè.

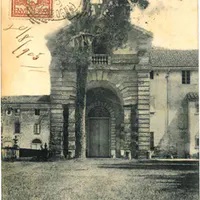

Attenzione: si può prenotare fino alle ore 23,59 del giorno antecedente la visita. Senza prenotazione non sarà possibile accedere al luogo il giorno dell'evento.
Le visite sono a cura del Gruppo FAI di Savena Idice Sillaro. In veste di “Apprendisti Ciceroni”, gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme accompagneranno i visitatori illustrando la storia della villa, delle famiglie che l'hanno abitata e del giardino, immersi nell'atmosfera unica di questo luogo ricco di arte e storia, tutto da scoprire.
«Passo dopo passo, vi sveleremo la storia e le forme del giardino e dettagli curiosi sull'affascinante mondo delle piante - sottolineano i volontari del Gruppo FAI di Savena Idice Sillaro -. Una visita guidata lungo i suoi viali alberati dove crescono innumerevoli varietà, accompagnati da una tazza di tè e da un'atmosfera unica. A seguire, la visita proseguirà nelle sale interne della villa».
Info e prenotazioni: https://fondoambiente.it/luoghi/palazzina-legnani-malvezzi?gfp
La Palazzina Malvezzi Campeggi, già Legnani
Testo a cura di Gruppo FAI di Savena Idice Sillaro
Edificata nella prima metà del Cinquecento la Palazzina Legnani è un perfetto esempio della tipica villa bolognese, sia per gli aspetti costruttivi che stilistici. Dall'elegante casino porticato cinquecentesco alla monumentale facciata realizzata nel corso dell'ampliamento settecentesco, tutto è studiato per conseguire un grande effetto scenografico, pur mantenendo una funzionalità necessaria nelle tenute aristocratiche, con ambienti di servizio, ma anche abitativi e di rappresentanza, caratterizzando una porzione di campagna che conserva ancora oggi gli aspetti storici del paesaggio, contraddistinto da un assetto territoriale studiato per unire e controllare i possedimenti terrieri. Il capostipite della famiglia Legnani fu Giovanni da Legnano, che ottenne nel 1378 la cittadinanza di Bologna. Battista, il suo unico figlio maschio legittimo, lasciò l'eredità nel 1463 ai figli Antonio Maria, Paolo Antonio e Guglielmo. Sarà Antonio Maria Legnani, nel 1506 entrato nel nuovo Senato bolognese, a dare lustro e ricchezze al casato, con un lungimirante progetto di investimenti concentrati soprattutto nel territorio di Varignana.
Marcello, esponente di un ramo cadetto dei Legnani, fu probabilmente il committente della Palazzina. Conosciamo l'aspetto cinquecentesco della villa grazie a Egnazio Danti, che documenta il Palazzo con un disegno del 1578 e una didascalia che la descrive come “il più gentile palazzo […] et sotterra ha una bellissima fontana sotto il portico». Era la tipica villa dell'aristocrazia cinquecentesca, con una loggia passante centrale, uno scalone accessibile dalla loggia e le cantine interrate, impianto mantenuto nonostante le trasformazioni settecentesche. Anche all'esterno il modello della classica villa bolognese è ben identificabile: nel disegno del Danti la villa si presenta con un portico a cinque arcate, elemento che nobilita la facciata e ritorna nella gran parte delle ville, derivato dal palazzo urbano bolognese come a sottolineare lo stretto legame tra la villa rurale e la dimora di città. Sappiamo dai libri contabili e dai disegni di Giuseppe Maria Ghelli del 1744 e di Girolamo Legnani Ferri del 1785 che sia nel Seicento che nel Settecento si eseguirono lavori e ampliamenti, per adattarla al nuovo ruolo dei suoi proprietari nella vita politica bolognese. Si devono quindi ai discendenti di Marcello Legnani gli interventi successivi. Nel 1631 fu costruito l'oratorio, per il quale ottennero da Papa Innocenzo X nel 1645 un breve di indulgenza plenaria applicata alla loro cappella nel giorno dell'Assunzione. Nel 1637 vennero eseguiti alcuni lavori sulla conserva, che si trova tutt'ora sotto la Palazzina, vicino alle cantine, con grandi stanze e una ripida scala che scende per alcuni metri nella monumentale ghiacciaia. Tra il 1667 e il 1668 vennero rinnovate le decorazioni della villa, forse i fregi nelle sale al piano terra, mentre le quadrature della loggia furono commissionate da Girolamo Legnani nel Settecento. Si decise inoltre la chiusura del portico, che venne murato e trasformato in una lunga galleria chiusa, aperta verso l'esterno da tre grandi portoni centinati.
Nella seconda metà del '700 la Palazzina subì un rinnovamento architettonico dettato dalla necessità di adattare la dimora al nuovo ruolo del proprietario, Girolamo Legnani Ferri, senatore bolognese dal 1757. Risale al 1764 il progetto di ampliamento dell'oratorio e di rifacimento della casa fattorale a est della villa padronale, che aveva triplice funzione, come si evince dalla divisione degli spazi interni: di servizio con la scuderia al piano terra e di abitazione, sia del fattore sul lato meridionale, che padronale secondaria, con ingresso dal portale centrale, più ornato. Scenografico è lo scalone nel vano centrale, grazie a un bell'apparato decorativo e le rampe a forbice. I lavori si conclusero entro il 1769. Oggi la ammiriamo per la sua architettura di rustica e grandiosa eleganza, con le due torrette che sarebbero dovute essere della stessa altezza della villa, per offrire continuità visiva tra i due edifici, ma nel 1788, forse a causa della morte dell'unico figlio maschio, i lavori alla Palazzina vennero interrotti al primo piano lasciando l'opera incompleta. Un disegno di Pio Panfili e un dipinto ottocentesco dello scenografo Domenico Ferri, ancora oggi conservato nella villa, ci mostra come sarebbe dovuta essere, con il corpo cinquecentesco innalzato per ottenere un piano nobile abitabile. Il livello superiore fu completato invece solo fino a un'altezza di circa quattro metri, mentre avrebbe dovuto elevarsi per circa il doppio e chiudersi con una trabeazione e un timpano sormontante le tre campate centrali, con al centro lo stemma della famiglia e la corona. La facciata è ora caratterizzata dalla divisione orizzontale in due parti e da cinque arcate, le due più esterne aperte su tre lati, quelle centrali invece chiuse e occupate da un grandioso salone interno coperto da volte a botte e a vela, con un bel portale con telamoni e aquile che funge da collegamento con il corpo antico. Il bugnato elegante e i capitelli dorici dei pilastri che sorreggono gli archi del portico rendono la facciata elegante e maestosa. Non è certo l'autore dell'opera, in quanto non sono pervenuti a noi contratti o pagamenti ma, sebbene inizialmente attribuita ad Angelo Venturoli, i caratteri stilistici della Palazzina sembrano rimandare a Francesco Tadolini, tecnico di fiducia del Legnani. Non è possibile però escludere completamente il nome di Cesare Malvasia, patrono di Tadolini, che era imparentato con Girolamo Legnani perché figlio della zia paterna Ginevra. Nel 1799 Girolamo vendette l'intera tenuta alla figlia Teresa, sposata con Camillo Malvezzi Locatelli dei conti della Selva. Da Teresa, per eredità, la Palazzina pervenne al figlio Pietro Paolo e successivamente a Emilio e Carlo Antonio, nati da Antonio Malvezzi Campeggi. Francesco Malvezzi Campeggi, figlio di Carlo Antonio, ereditò i beni e a sua volta li trasmise al figlio Camillo. Alla sua morte nel 1967, le nipoti Rosa, Dialta e Laura incaricarono l'ingegner Alessandro Pascale di occuparsi delle riparazioni necessarie dovute ai danni bellici della Seconda Guerra Mondiale, con la ricostruzione dell'ala destra del piano superiore della facciata, andata distrutta, il restauro degli apparati decorativi del salone e la collocazione di nuovi vasi sul parapetto del marciapiede della villa, in sostituzione di quelli andati dispersi durante il conflitto.
Bibliografia: Daniele Pascale Guidotti Magnani, “Il Gentile Palazzo dei Legnani. Appunti per un'analisi stilistica dal Cinquecento al Neocinquecentismo” Pier Luigi Perazzini, “La Palazzina Malvezzi Campeggi, già Legnani”